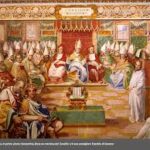A lungo si è sentito discorrere sulle radici d’Europa; dal lascito della Koinè greca a quello dell’Imperium di Roma antica, passando per le ineluttabili – e fin troppo messe in discussione – radici cristiane. Con l’inizio del 2013 si è aperto il cosiddetto “anno costantiniano”, l’anniversario dei 1700 anni dall’Editto di Milano – 313 d.C. –, attraverso il quale si sancì per le comunità cristiane dell’Impero la piena libertà di culto.
Secondo editto di tolleranza e neutralità imperiale nei confronti di qualsiasi fede – il primo fu l’editto di Serdica del 311 ad opera di Galerio (250 ca – 311 d.C.) –, fu voluto di comune accordo da Costantino I (274-337 d.C.) e l’allora imperatore d’Oriente Licinio (265-325 d.C.), prima della sconfitta di quest’ultimo nella battaglia di Crisopoli – 324 d.C. – e l’unificazione dell’Impero sotto il primo. Punto cruciale nella storia del Cristianesimo e dell’Europa, l’editto di Milano fu voluto da Costantino, sul presupposto dell’ormai elevato numero di aderenti alla religione cristiana, inclusi esponenti dell’élite nobiliare romana, e dell’inarrestabile sua ascesa.
L’anniversario dell’anno costantiniano, ovvero dell’editto del 313 d.C., porta inevitabilmente a una riflessione sulla figura dell’imperatore Costantino I e sul suo incidere nello sviluppo del Cristianesimo e future radici cristiane europee.
Lungi dal convertirsi se non in punto di morte, Costantino seppe rivelarsi non solo un abile soldato ma anche un profondo conoscitore della situazione sociale e religiosa dell’Impero di allora; intuì l’inarrestabile diffondersi del Cristianesimo e lo favorì, consapevole dell’importanza di avere non solo l’appoggio delle Chiese di tutta la romanità, ma che queste fossero unite e concordi. Per il bene dell’Impero e della sua stabilità tutto questo si rendeva vitale; ma la cristianità, minata nella compattezza dalle prime eresie della sua storia e retta da una tradizione trasmessa oralmente, urgeva di trovare una propria stabilità interna. Di qui la scelta destinata a segnare la storia della Chiesa: la convocazione a Nicea – attuale Iznik, Turchia –, da parte di Costantino, del primo concilio ecumenico nella storia della Chiesa – 325 d.C. –.
Le comunità cristiane che si stavano sviluppando nella società, benché apparentemente coese, nella realtà mancavano di una reale formula canonica che le unisse in un vincolo inscindibile; probabilmente ogni comunità poteva contare su un proprio “credo”, trasmesso oralmente dai secoli precedenti. Inoltre, all’epoca costantiniana, stava prendendo piede l’eresia “ariana”, concepita dal presbitero alessandrino Ario (256-336 d.C.), questa dottrina negava la natura divina di Cristo, concepito come “creazione” di Dio e non parte della medesima sostanza: dottrina che poneva il Figlio di Dio al di fuori del divino.
Le dispute insite alla Chiesa rischiavano di dividere le comunità dove, giova ricordare, non esisteva ancora una supremazia papale: al vescovo di Roma si riconosceva un ruolo di prestigio e di autorità – Roma era sempre il luogo dove riposavano i resti dei Santi Pietro e Paolo – ma non una sovranità spirituale sulle altre sedi, dove un ruolo di prestigio era egualmente ricoperta da Costantinopoli, Alessandria d’Egitto, Antiochia e Gerusalemme. Ciò rischiava di frantumarne l’unità e di favore spinte centrifughe all’interno dell’Impero. Costantino, consapevole del rischio, intervenne per porre una soluzione. Di qui la convocazione del concilio, destinato a solidificare le fondamenta della cristianità; con questo si auspicava l’affermazione di un dogma di fede sulla natura di Cristo cui fossero vincolati i cristiani.
Benché fossero invitati tutti i vescovi, vi presero parte solamente alcune centinaia, quasi tutti appartenenti alle Chiese orientali, mentre da Roma giunsero due rappresentati per conto di Papa Silvestro I (?-335). Presero parte al concilio anche il discusso Ario, già scomunicato dal Sinodo di Alessandria – 321 d.C. –, il suo protettore, l’influente vescovo Eusebio di Nicomedia (?-342 d.C.) e il vescovo di Myra – e futuro Santo – Nicola (270 ca – 343 d.C.). In totale presero vi presero parte circa trecento uomini di Chiesa. Ebbe inizio il 20 maggio 325 d.C.
Il concilio si svolse in un clima tutt’altro che sereno; si dice che San Nicola, irritato dall’ostinazione e la presunzione di Ario, giunse persino a schiaffeggiarlo.
Dopo aspre dispute il concilio si concluse il 25 luglio 325 d.C. con la condanna dell’arianesimo e il conseguente esilio di Ario, e sebbene l’eresia ariana fosse lungi dall’essere vinta – sembra che lo stesso Costantino si facesse battezzare in punto di morte da un prete ariano –, tale condanna definì il dogma della natura divina di Cristo, pilastro della fede cristiana.
Assieme all’arianesimo, crollò conseguentemente anche la dottrina cristologica adozionista, che voleva in Cristo un essere puro, adottato ed elevato a Figlio di Dio al momento del battesimo sul Giordano per compiere la propria missione di redenzione per l’umanità, ma sempre inferiore a Dio.
Durante il concilio furono giudicate eretiche e conseguentemente condannate anche le dottrine novaziana e melaziana[1], mentre si stabiliva che le celebrazioni pasquali non potessero coincidere con la Pasqua ebraica – che si celebrava il 14 di Nisan , il primo mese del calendario ebraico dalla liberazione dalla schiavitù egiziana o il settimo secondo il computo ordinario– passo decisivo nella rottura con gli ultimi legami celebrativi con l’ebraismo. Infondate sembrerebbero invece le voci illuministe, avanzate da Voltaire e successivamente diffusisi, della scelta di distinguere i quattro Vangeli canonici da quelli apocrifi.
La decisione più importante sul piano storico e religioso fu l’adozione del dogma di fede legato all’homooùsion, ovvero la dottrina della “consustanzialità” del Padre e del Figlio, espressa attraverso una dichiarazione di fede, il Credo Niceno, che ancora rappresenta oggi il cuore delle celebrazioni cristiane.
Il Credo costituì – e costituisce tutt’ora -, attraverso la propria formulazione, l’essenza del Cristianesimo; in esso si esplicita la natura di Cristo, Figlio di Dio e parte della stessa Sostanza, pertanto “generato e non creato” dal Padre – chiaro riferimento di condanna dell’arianesimo –.
Nel Credo si dichiara inoltre un altro pilastro del Cristianesimo, la nascita del Figlio di Dio da Maria “vergine”, ribadendone il dogma già affermato nel Vangelo secondo Matteo.
Nonostante la controversia ariana proseguisse ancora, il Credo Niceno stabilì la formula di fede per antonomasia e, benché venisse parzialmente modificato al successivo concilio di Calcedonia del 451 d.C. – prendendo l’appellativo di Credo Niceno-Costantinopolitano – , incarna tutt’ora l’essenza religiosa della maggior parte delle Chiese cristiane, compresa la grande Chiesa Ortodossa, scissa da Roma col grande scisma d’Oriente del 1054, che vide tra le cause principali la diatriba legata al Filioque[2] e alla natura umana e divina del Figlio di Dio – tutt’ora molto sentita -.
Punto di svolta nella storia del Cristianesimo, il concilio di Nicea I, rappresenta con l’Editto di Milano del 313 la linfa che alimenta da secoli le profonde, e mai gelate, radici cristiane dell’Europa.
[1] La dottrina novaziana, ideata dal vescovo Novaziano (ca. 220 – 258 d.C.), passato alla storia come il primo antipapa in contrapposizione al legittimo pontefice Cornelio (180 ca. – 258 d.C.) negava la possibilità di una remissione dei peccati attraverso il tramite del pentimento e l’assoluzione da parte della Santa Chiesa. La polemica era sorta dopo le persecuzioni dell’imperatore Decio e alla possibilità di riammettere coloro che avevano abiurato la fede cristiana per timore, che Novaziano negò sempre e, seppur indirettamente, questo negava alla Chiesa la possibilità di assolvere chi si pentiva.
L’eresia meleziana, prendente il nome dal vescovo di Licopoli Melezio (ca fine III/inizio IV sec. d.C.), violava la sacra legge per cui era proibito ad un vescovo di ordinare sacerdoti al di fuori della propria diocesi.
[2] Filioque, ovvero la formulazione di rito latino in cui lo Spirito Santo “ […] procede dal Padre e dal Figlio”, negata dalla Chiesa Ortodossa che non accetta “il Figlio”, sia per ragioni teologiche legate alla natura umana del Figlio di Dio – esaltata nel rito latino al pari di quella divina – sia perché violerebbe quanto stabilito dal concilio di Efeso nel 431 d.C., che aveva stabilito l’immodificabilità del Credo Niceno – mentre l’aggiunta di Calcedonia non modificherebbe il senso del Credo originale, tale aggiunta lo farebbe –.