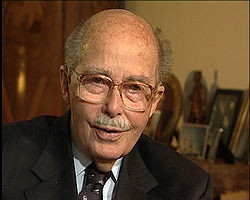 Da Otto d’Asburgo si poteva imparare come il malinterpretato concetto di “Grazia di Dio” andasse compreso. La responsabilità che egli portò, ebbe profonde radici nella storia europea e con il suo agire generò nuovi frutti come antesignano dell’idea di Paneuropa. Ecco la testimonianza di Stephan Baier, suo assistente parlamentare dal 1994 al 1999.
Da Otto d’Asburgo si poteva imparare come il malinterpretato concetto di “Grazia di Dio” andasse compreso. La responsabilità che egli portò, ebbe profonde radici nella storia europea e con il suo agire generò nuovi frutti come antesignano dell’idea di Paneuropa. Ecco la testimonianza di Stephan Baier, suo assistente parlamentare dal 1994 al 1999.
Era una fredda sera di dicembre del 1996 dopo un’intensa giornata di lavoro al parlamento europeo di Strasburgo. In un piccolo locale turco tra la stazione e il nostro hotel Monopole Metropole discutevo con Otto d’Asburgo di grazia e dannazione, di destino e fatalità, della misericordia di Dio e della sua giustizia. Poco prima di mezzanotte, egli tirò questa conclusione: la misericordia di Dio ha sempre la preminenza, disse sicuro di sé. Sperava che, nel momento della morte, ogni uomo potesse sentire la realtà divina tanto da convertirsi anche in quello stesso momento. Convinto che il purgatorio fosse necessario e sensato per la purificazione dell’anima umana, che solo dopo una tale preparazione si può incontrare Dio, credeva alla misericordia di Dio rispetto alla sua prossima fine.
Già nel 1984 aveva risposto alla domanda posta dal periodico del Frankfurter Allgemeine, “Come vorreste morire?”, “Nella grazia di Dio”. Nelle prime ore del 4 luglio 2011 è stato così. Otto d’Asburgo è morto così come era vissuto: nella convinzione che davanti a Dio non contano il titolo o gli onori ma solamente la fede e le buone opere.
La comprensione della vita e della morte sono strettamente amalgamate. A suo padre, l’imperatore Carlo I – morto nel 1922 e proclamato beato nel 2004 – era stato fatto crollare il regno e gli fu sottratto il trono, ma non gli si poté sottrarre la consapevolezza di avere una indelegabile e inamovibile responsabilità per i popoli del Danubio. Con questa eredità si fece avanti il figlio. Solo in questi termini è comprensibile il suo impegno per quei popoli per la cui libertà egli si adoperò per così tanti decenni con totale dedizione. Non gli importò mai della sua persona, dell’onore o della fama, del potere o della carriera. Né calunnie e ingiurie, né i due allontanamenti forzati dalla propria patria – alla fine della prima e della seconda guerra mondiale – né le leggi discriminanti per gli Asburgo poterono trattenerlo dall’impegnarsi con tutte le sue forze per coloro dei quali gli era stata assegnata la responsabilità da Dio e dalla storia.
Niente di ciò che aveva raggiunto o compiuto o di cui faceva parte, segretamente o apertamente – dalla ricostituzione dell’Austria fino alla caduta della cortina di ferro – egli considerava un merito. Otto d’Asburgo possedeva quell’indipendenza interiore, quell’equidistanza dell’anima tra successo e sconfitta, che è il frutto della vera umiltà. Di questo era sempre certo: tutto è per grazia di Dio. Fintanto che procede, l’uomo ha il suo dovere da compiere senza nemmeno pensare al successo o alla sconfitta poiché ogni cosa che riesce bene, viene da Dio. Questa stessa conoscenza egli l’attinse dalla vita e dalla morte di suo padre. Altri hanno speculato su che tipo di esperienza debba essere stata, il vivere la dipartita del padre che egli stesso descrisse nel suo libro Allora cominciò il nostro futuro. E questo fu il suo insegnamento da ciò: «Quando si incontra il proprio Creatore vale prima di tutto il compimento dei doveri e la buona volontà. Dio non pretende dall’uomo che gli si portino bollettini di vittoria: il successo proviene da Lui. Da noi si aspetta solo che facciamo del nostro meglio».
Chi si getta nel lavoro politico con la coscienza di ciò, non si lascia abbattere da calunnie, scherno o insuccesso. Il crollo dell’Impero Austro-ungarico, gli anni dell’esilio, l’ascesa al potere di Hitler e l’annessione dell’Austria, l’imprigionamento dei fedeli da parte dei nazisti, la seconda guerra mondiale e la spartizione dell’Europa e il personale contraccolpo per Otto d’Asburgo: nulla lo abbatté. Ogni difficoltà era uno sprone per rispondere della sua responsabilità, profondamente sentita, davanti a Dio e ai popoli. In Allora cominciò il nostro futuro scriveva: «La politica non è la caccia ai privilegi, ai mandati, alle funzioni e ai posti di potere. Non è nemmeno la ricerca della considerazione personale o del successo. La politica è il compimento del proprio dovere interiore, tangibile espressione dell’amore e della dedizione all’umanità».
Chi, come questo Asburgo, ascrive tutto il successo alla grazia di Dio, non si attribuisce meriti e rimane umile anche quando è famoso e rispettato e raggiunge il successo. E non può nemmeno diventare un dittatore, poiché sa che la politica è solo servizio e solo Dio è l’assoluto. Egli è anche contrario a ogni totalitarismo poiché solo Dio è il totuum, il tutto compiuto dello sperare e del tendere umani.
Certo non tutti, ma comunque i migliori tra i suoi antenati erano consci di questo, come sovrani. Essi consideravano il potere regale come servizio alla volontà di Dio, come compimento di un dovere più grande di se stessi. Questo è il migliore è il più profondo senso della già citata – e mal compresa – “Grazia di Dio” che nel migliore dei casi significa preminenza in umiltà e responsabilità. Ma la storia ha voluto che Otto d’Asburgo, erede di una millenaria dinastia imperiale, non divenisse sovrano. Nato all’alba della prima guerra mondiale, Otto aveva solo sei anni, quando crollò il regno multietnico nel cuore dell’Europa e con esso tutto l’occidente. Da lungo tempo l’Impero era stato divorato e diviso da nazionalismi, ignorati o sottovalutati dal vecchio Francesco Giuseppe. Da lungo tempo «la morte – come scrisse il grande letterato galiziano di origine ebraica Joseph Roth – prendeva con le sue ossute mani il calice da cui bevevamo pasciuti e incoscienti».
Scavando psicologicamente più a fondo, Joseph Roth aveva catturato le cause della caduta nel suo romanzo La marcia di Radetzky quando fa dire, retrospettivamente, nel 1914 al suo conte Chojnicki: «Quest’epoca non ci vuole più! quest’epoca vuole costruirsi per la prima volta stati nazionali autosufficienti. Non si crede più a Dio. La nuova religione è il nazionalismo. I popoli non vanno più nelle chiese. Vanno alle società nazionali. La monarchia, la nostra monarchia è basata sulla devozione: sulla fede che Dio ha scelto gli Asburgo per governare su così tanti popoli cristiani. Il nostro imperatore è un fratello del Papa, è sua Maestà Apostolica Imperial-regia, nessun altro è apostolico come lui, nessun’altra Maestà in Europa così legata alla grazia di Dio e alla fede dei popoli nella grazia di Dio. L’imperatore tedesco governa, se Dio glielo concede; solo eventualmente dalla grazia della nazioni. L’imperatore d’Austria-Ungheria non deve essere abbandonato da Dio. Ma ora Dio lo ha abbandonato!»
Nessun dubbio che il tardo Joseph Roth fu un fervente monarchico che all’impero asburgico – come erede del Sacro Romano Impero – ormai in macerie, attribuiva postumamente una dimensione pressoché sacrale. In esso vedeva più che uno stato il Sacrum Imperium, il vero ordine dei popoli cristiani che aveva portato all’estinzione del nazionalismo anticristiano e cadde poi in un sanguinoso caos, perduta la conoscenza della catastrofe della prima guerra mondiale, apocalittico presagio dell’albeggiare della nuova catastrofe della seconda guerra mondiale. In un testo accompagnatorio della prestampa de La marcia di Radetzky Roth scriveva: «una tremenda volontà della storia ha portato alla distruzione della mia vecchia patria, il regno austro-ungarico. Ho amato le virtù e i privilegi di questa patria, e oggi che è morta e perduta amo pure i suoi errori e le sue debolezze.»
Roth fu preso per “mitomane” e il suo amore per il vecchio impero come nostalgia. Egli percepiva però, attraverso gli errori e le debolezze dei monarchi, i tratti del concetto di Impero cristiano occidentale. E presagì con molta lungimiranza la vicina catastrofe che prendeva le mosse dalla vittoria della nuova “religione”, a partire da un nazionalismo che si elevava sempre più a totalitarismo. Nella monarchia austriaca la signoria comportava sempre l’umiltà del servizio, poiché l’imperatore era conscio della propria responsabilità davanti a Dio ed alla storia. Al contrario i dittatori giunti al potere per mezzo del nazionalismo non conoscevano né questi limiti né una qualche forma di umiltà. Le guerre e le catastrofi del XX secolo hanno a che fare proprio con questo.
Nel 1965 Otto d’Asburgo, in un lavoro dal titolo Corrispondenza tra i Papi e gli imperatori austriaci ebbe a scrivere: «L’impero austro-ungarico era tradizionalmente per sua essenza sovranazionale e proprio per questo si trovava in una posizione di forte contrasto con lo spirito del XIX secolo, dovendo alla fine soccombere in una guerra impari. Per quel tempo si trattò di un anacronismo nel vero senso della parola e il “crepuscolo degli dei” del 1945 dimostrò che i suoi principi per la costituzione del continente erano assolutamente necessari.» L’Austria-Ungheria era anacronistica al tempo del nazionalismo giacché era andata perduta l’idea di unità dell’occidente cristiano ed era pure anacronistica nel momento del secolarismo radicale poiché non era più compresa l’idea di “Grazia di Dio”.
Nel 1916, quando morì il vecchio Francesco Giuseppe, e il giovane Carlo I divenne imperatore, a qualcuno balenava ancora l’idea di che cosa fosse la Grazia di Dio. All’incoronazione di Carlo a re d’Ungheria, il primate ungherese, il Cardinale Johannes Csemoch recitò questa preghiera: «Oggi accogli l’onore regale e assumi l’incarico di essere re sui popoli credenti che ti vengono affidati … Ma se consideri che tutto il potere è di Dio, attraverso il quale i sovrani regnano e i legislatori decidono cosa è giusto, tu renderai conto a Dio stesso del gregge che ti è stato affidato». Non si potrebbe formulare con migliori parole quale umiltà richieda la Grazia di Dio quando è correttamente compresa. Così rispose Carlo prima che gli fosse posta sul capo la corona di Santo Stefano: «Io Carlo, per volontà di Dio futuro re degli ungheresi, riconosco e prometto davanti a Dio e ai suoi angeli di provvedere alle leggi alla giustizia e alla pace per il bene della chiesa di Dio e dei popoli a me affidati.»
Con tale giuramento egli non si sentiva solo autorizzato, ma vincolato moralmente a impegnarsi in entrambi i tentativi di restaurazione miseramente falliti. Con questa responsabilità divina, il re non poteva semplicemente mettersi a riposo e osservare passivamente mentre il paese cadeva nel caos e mentre il popolo veniva consegnato nelle mani di potenti politici radicali. Allo stesso modo, Otto d’Asburgo, come suo erede, non se ne stette a guardare i dittatori rossi e neri far cadere nella guerra e nel caos i popoli europei. Gettarsi nella battaglia con tutte le proprie forze e con tutti i mezzi a disposizione – fossero anche pochi – contro Hitler e Stalin, Beneš e Milošević era di più che un gioco politico o tattico. Si trattava di un dovere morale che non teneva conto delle circostanze della Realpolitik.
Nel suo libro L’Ordine sociale di domani pubblicato nel 1957, Otto d’Asburgo scriveva che è «il più alto compito al mondo per uno stato è essere difensore e antesignano del diritto naturale nella collettività.» Il diritto naturale è quell’insieme di princìpi eternamente validi che il Creatore stesso ha dato al mondo come “costituzione” non scritta ma dal valore vitale. In questo contesto egli prese il suo ruolo di monarca: «Sarebbe sbagliato se un sovrano volesse vedersi per grazia di Dio come qualcosa di speciale, ma piuttosto l’espressione “per Grazia di Dio” dovrebbe ricordargli che egli non è stato chiamato al suo posto per un merito proprio, ma per rendere prova del suo diritto attraverso la giustizia e l’incessante attività.»
Otto d’Asburgo si dichiarava decisamente figura cristiana. Nel suo libro Europa. Garante della libertà scriveva: «Si danno solo due concezioni dell’uomo, quella cristiana e quella materialista. Il credente vede in sé e nel prossimo un’immagine di Dio, a cui il Creatore ha dato dei diritti che non gli possono essere sottratti né dal singolo né da uno stato, né da un tiranno né dalla incerta volontà di una maggioranza. Egli riconosce che i diritti dell’uomo stanno più in alto di quelli di una collettività. D’altro canto i materialisti per i quali l’uomo non è che un caso nel potere della materia, non gli riconoscono nessun diritto superiore.»
Per concezione cristiana la politica trova i suoi confini laddove si deve dare a Dio ciò che gli si addice e dove si deve dare all’uomo ciò che gli si addice come immagine di Dio. Questa visione rende liberi da qualunque pretesa totalitaria dello stato, della politica o di qualsiasi altra potenza terrena. Essa mette anche in mostra tutto il potere dello stato nei suoi limiti, indipendentemente che si tratti di una monarchia o una repubblica, tirannia o democrazia. All’imperatore Francesco Giuseppe viene attribuita la frase per cui il compito del monarca consisterebbe nel difendere i suoi popoli dai loro governi: una ormai classica descrizione del ruolo di un monarca cristiano.
A questo punto diventa visibile l’ampia rottura tra l’antichità pagana e il medioevo cristiano, tra l’impero romano pre-costantiniano e l’impero cristiano. Gli imperatori cristiani erano consci (nel migliore dei casi) di dover giustificare il loro operato davanti al Creatore del mondo – che è al contempo il nostro Salvatore. Sapevano sostanzialmente anche che esiste un confine tra il regno dell’imperatore e il regno di Dio. Diversamente che a Bisanzio, in occidente la lotta per le investiture nel medioevo non era una battaglia di princìpi ma una battaglia territoriale. Imperatore e Papa conoscevano la differenza tra gladius temporalis e gladius spiritualis, tra imperium e sacerdotium.
Proprio questa differenza tra mondano e spirituale, tra delitto e peccato, tra diritto secolare e spirituale è la base – oggi nuovamente in grave pericolo – dello stato di diritto. Solo con il confinamento della religione nella sfera privata il potere ebbe modo di tornare assolutistico e più tardi, nel XX secolo, totalitario. Così divenne evidente che uno stato che non dà più a Dio ciò che è di Dio calpesta anche i diritti dell’immagine di Dio, cioè l’uomo. «Diritto divino e diritto dell’uomo esistono e cadono insieme» come ebbe a dire Giovanni Paolo II alla beatificazione di Padre Rupert Meyer nel 1987 a Monaco.
Otto d’Asburgo – assolutamente a ragione – vedeva nel Nazionalsocialismo «un’aspirazione neopagana», come scrisse in una lettera del 17 febbraio 1938 al Cancelliere austriaco Kurt Schuschnigg. In questa lettera dice letteralmente: «Nell’impero tedesco infuria una sistematica battaglia contro il cattolicesimo, battaglia che alla lunga porterà alla sua eliminazione in ampi strati della popolazione».
Il fondatore del movimento Paneuropeo, Richard Coudenhove-Kalergi, scriveva nel 1937 a proposito dei totalitarismi rossi e neri: «L’uomo è una creatura di Dio. Lo stato è una creatura dell’uomo. Per questo lo stato esiste per il bene dell’uomo e non l’uomo per il bene dello stato.» Uno stato che non riconosca e rispetti questo principio diventa totalitario per forza di cose, dato che fa il contrario di ciò che noi identifichiamo come il vero ideale della Grazia di Dio. Si pone al di sopra degli uomini e anziché porsi come l’unico che sia chiamato a stare sopra l’uomo, si pone direttamente al posto di Dio.
Esortare una nazione all’umiltà verso Dio e l’uomo è una sfida erculea anche in una democrazia: questa sfida Otto d’Asburgo la prese su di sé con passione. Dotato di una rafforzata volontà tesa alla libertà personale – volontà che gli proveniva dalla sua battaglia contro le dittature del XX secolo – e di una sana sfiducia nella burocrazia, riuscì da questo a trarre delle conclusioni nel suo lavoro. La sua coscienza gli imponeva di sostenere costantemente ciò che egli riconosceva come buono, giusto e degno dell’uomo assieme a ciò che egli aveva accettato come sua responsabilità.
Questo era il lato soggettivo di una responsabilità ereditata e accettata. Esiste anche però un lato oggettivo: Otto d’Asburgo cercò sempre di tradurre per l’oggi e per il domani quel che di buono rimaneva dell’antico impero – tanto il Sacro Romano quanto l’Austro-ungarico. Questi due imperi erano stati compositi nazionalmente e linguisticamente, tolleranti e ben ordinati, uniti verso l’esterno e pluralisti verso l’interno. Questi princìpi sfociano nell’idea di Paneuropa che non è assolutamente coincidente con quella di Unione Europea.
Non i nostalgici ma i Paneuropei, che nel loro spirito assumono la responsabilità del domani, sono perciò i veri eredi di Otto d’Asburgo.
(Contributo tratto da Paneuropa Deutschland. Traduzione di Andrea Padovan)












